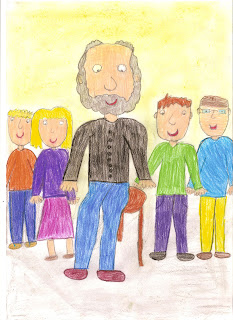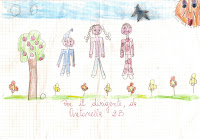Forenza ha sviscerato il suo passato templare in un convegno
Lilia Allamprese (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Forenza) ha esordito, nel suo preludio, ricordando che “l’incontro va a concludere il progetto ministeriale ‘Sulle orme dei Templari’, teso a valorizzare le radici storiche del territorio tramite una capillare disamina della storia locale”.
Una valorizzazione ad ampio spettro che, per le prossime serate estive, non esclude neanche l’aspetto ludico. Difatti, è stata commissionata a Pina Mastrodonato (artista genzanese già distintasi in altre occasioni per la sua maestria) un dipinto su pergamena raffigurante l’antico ‘gioco del
 l’oca’. Ma si tratta di una ‘spirale’, scandita da invitanti ‘oche’, di fatto ‘sui generis’: le caselle sono tutte contrassegnate da immagini di storia locale: monumenti, personaggi ed eventi inerenti al sito forenzese. Frutto di un lavoro certosino che ha impegnato la Mastrodonato, armata di pennellini e colori ad olio, per oltre un mese. Quindi è stata fatta stampare una gigantografia del lavoro che sarà utilizzata per giocarci: già sabato, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, ed in seguito nella villa comunale, ove resterà esposta.
l’oca’. Ma si tratta di una ‘spirale’, scandita da invitanti ‘oche’, di fatto ‘sui generis’: le caselle sono tutte contrassegnate da immagini di storia locale: monumenti, personaggi ed eventi inerenti al sito forenzese. Frutto di un lavoro certosino che ha impegnato la Mastrodonato, armata di pennellini e colori ad olio, per oltre un mese. Quindi è stata fatta stampare una gigantografia del lavoro che sarà utilizzata per giocarci: già sabato, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, ed in seguito nella villa comunale, ove resterà esposta.“I ragazzi imparano meglio, divertendosi – ha precisato la giovane preside –, e solo conoscendo le proprie radici, ci si può proiettare in maniera positiva verso il futuro”.
D’accordo con lei il Sindaco Mastrandrea e l’assessore Lambo. I quali hanno ribadito il ruolo della scuola quale ‘magistra vitae’ e rimangono convinti della necessità di continuare ad investire in ‘cultura’, “poiché se è vero che ciò non paga nell’immediato – hanno precisato –, è anche certo che, nel tempo, restituisce con interessi alti; quindi occorre essere pazienti e lungimiranti se si vogliono ottenere risultati significativi e stabili”.
Mastrandrea ha sentito anche il bisogno di mettere in chiaro che “il presente convegno organizzato con tanto impegno della scuola e dall’Amministrazione, è da riguardarsi come una sorta di esperimento alchemico che da mitologia, storia, tradizione orale e qualche congettura più o meno fondata, mira a mettere in moto un ‘volano’ che possa servire a trainare la cultura e l’economia sia del paese che di tutto il territorio limitrofo”.
Un ringraziamento particolare è andato gli studiosi presenti, per l’interesse volto a Forenza nel far luce su un periodo storico che l’ha vista protagonista in vicende fondamentali per la storia dell’Europa.
Punto di vista della storia ‘ufficiale’ su ‘Forenza e dintorni’
 Si sono profusi nel presentare una visione ortodossa del ruolo di questa parte della Basilicata in seno ai profondi mutamenti che continuamente rimodellarono gli ‘assetti geopolitici’ dell’ età medievale, Silvio Zotta ed Antonella Pellettieri. Il primo, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Napoli con una ‘lezione’ sulla storia di Forenza dai Longobardi agli Angioini: partendo dalla fondazione fino alla forma urbana trecentesca. L’altra, saggista e Dirigente di Ricerca al CNR, discettando con cognizione di causa attorno agli ‘Ordini religioso-cavallereschi’, un tema che – è stato la stessa Pellettieri a precisarlo – solo da vent’anni a questa parte, viene considerato non più come storia da lasciare ai margini poiché fortemente ideologizzata, bensì fenomeno indispensabile per comprendere un’ epoca che è stata cruciale per le sorti dell’Europa e che ha lasciato segni tangibili in molti luoghi, Lucania compresa.
Si sono profusi nel presentare una visione ortodossa del ruolo di questa parte della Basilicata in seno ai profondi mutamenti che continuamente rimodellarono gli ‘assetti geopolitici’ dell’ età medievale, Silvio Zotta ed Antonella Pellettieri. Il primo, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Napoli con una ‘lezione’ sulla storia di Forenza dai Longobardi agli Angioini: partendo dalla fondazione fino alla forma urbana trecentesca. L’altra, saggista e Dirigente di Ricerca al CNR, discettando con cognizione di causa attorno agli ‘Ordini religioso-cavallereschi’, un tema che – è stato la stessa Pellettieri a precisarlo – solo da vent’anni a questa parte, viene considerato non più come storia da lasciare ai margini poiché fortemente ideologizzata, bensì fenomeno indispensabile per comprendere un’ epoca che è stata cruciale per le sorti dell’Europa e che ha lasciato segni tangibili in molti luoghi, Lucania compresa.Il punto di vista di Zotta è di tipo wittgensteiniano: su ciò di cui non si può parlare, è meglio tacere. Cosicché la sua rinuncia a conferire al paese natio un ruolo di spicco riguardo alla genesi dell’Ordine dei Templari è netta e sfrontata. Ma la storia che narra sull’origine di Forenza è precisa e basata su documenti; e, nel peggiore dei casi, su un’attenta analisi etimologica della toponomastica rurale. “L’evento cruciale – chiarisce nel corso della sua lunga esposizione – è quello dell’843: il territorio forenzese è sotto il dominio degli Alemanni (combattenti longobardi), i quali hanno imposto un feudalesimo basato sulla forza. L’arrivo dei Saraceni, induce qualche centinaio di uomini a rifugiarsi sulla montagna ed a fortificarla: nasce Forenza. Ma solo nel 1368 – continua Zotta – viene collocata, presso la chiesa di San Nicola, la prima campana: ciò significa che il Comune è finalmente in grado di autogovernarsi”.
Una storia senza infamia né lode, dunque, che vede comunque la zona del Vulture-Alto Bradano al centro di prove di forza tese a rovesciare equilibri tutt’altro che meramente locali.
Pellettieri è dello stesso avviso, ma il suo interesse è centrato su quanto si muove attorno ai diversi gruppi di ‘monaci armati’ che funsero da ‘guardia del corpo’ (e da incaricati al ‘ricovero’) per gli ingenti flussi di uomini che si recavano nei luoghi della Terra Santa in seguito al movimento delle Crociate. La studiosa del CNR non nega che la terra lucana, ed in particolare Forenza, abbia costituito un luogo di transito privilegiato (nonché base logistica strategica) per i Poveri Cavalieri di Cristo e per altri Ordini (“ad esempio, Melfi – dice – è stata probabilmente la prima Domus europea legata all’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme”), ma esclude categoricamente che Ugo dei Pagani possa essere identificato col fondatore dell’Ordine Templare.
Punto di vista ‘non ortodosso’ del ruolo di Forenza e delle zone limitrofe all’epoca del dominio dei Normanni e delle Crociate (Franculli, Glinni, Vernavà)
Canio Franculli, Emanuele Vernavà e Raffaello Glinni sono i relatori che hanno palesato una visione un po’ meno ortodossa riguardo al tema del convegno. I primi due, dirigenti scolastici appassionati di storia locale; l’ultimo, ingegnere di origini acheruntine residente a Roma, il quale ha iniziato ad interessarsi al tema compiendo ricerche sulle origini (nord-europee) della famiglia d’appartenenza.
L’esposizione di Franculli (“Il territorio lucano al tempo delle Crociate”), pur vertendo sui cardini principali dell’argomento è strutturata in maniera tale da trascenderli. La sua è piuttosto una meta-analisi dei fatti. “Perché – si chiede in sostanza lo studioso, già autore di saggi – nei libri di storia con la ‘S’ maiuscola non si parla mai di Lucania, nonostante l’epoca che stiamo affrontando sia ricca di fatti cruciali di importanza a livello europeo?” Senza contare quelli già palesati da Zotta e Pellettieri, Franculli ne cita uno che basta da solo a rendere l’idea: “nel 1089 – dice – presso l’Abbazia Benedettina di Banzi, Urbano II incontrò ben 32 Vescovi allo scopo di prendere importanti decisioni in merito all’imminente ‘guerra santa’, ma questo evento non è mai citato nei testi scolastici”.
La spiegazione che Franculli riesce ad offrire per questa sorta di ‘invisibilità’ del nostro territorio è semplice: la Lucania non viene nominata perché ‘non esiste’, ovvero non ha un nome, ed i suoi ‘luoghi’ passano continuamente dall’una all’altra delle regioni limitrofe, fino a perdere quasi consistenza. Ricostruire questa identità, secondo Franculli, deve costituire uno degli obiettivi principali di una ricerca storica che miri a cercare ‘verità’ che prescindano da “dogmi santificati”.
Specificatamente sui Templari, invece, la disamina di Varnavà, volta soprattutto a cogliere il dualismo caratterizzante di monaco-guerriero, armonizzato con sapienza da San Bernardo nella sua famosa regola scritta per l’Ordine. Una storia che non lesina in quanto a misteri ancora irrisolti (cosa rappresentava Bafometto, ad esempio?) ed a particolari assai suggestivi.
Infine Glinni. La sua è una visione un po’ esoterica; ma, da buon ingegnere, la presenta con rigore, avvalendosi dell’uso di un programma per computer, grazie al quale riesce a far vedere come, partendo da considerazioni di natura prettamente matematica, viene fuori la pianta della Cattedrale di Acerenza. L’algoritmo di base, applicato partendo da un rettangolo (particolare, ma non scelto a caso) si basa sulla reiterazione della nota regola del ‘rapporto aureo’, facilmente riscontrabile anche in natura, ad esempio nella disposizione dei semi in un girasole o nella spirale di una lumaca.
Glinni è convinto che i Normanni possedevano conoscenze che andrebbero riscoperte; grazie alle quali si potrebbe riuscire a far luce su molte cose, semplicemente cominciando a guardarle da una prospettiva diversa. E ciò, naturalmente, vale anche per quel che riguarda i Forenza e i Templari.
C’è fermento, insomma, sull’argomento. E ciò, in un modo o nell’altro, non può che far bene alla nostra Lucania.
Gianrocco Guerriero